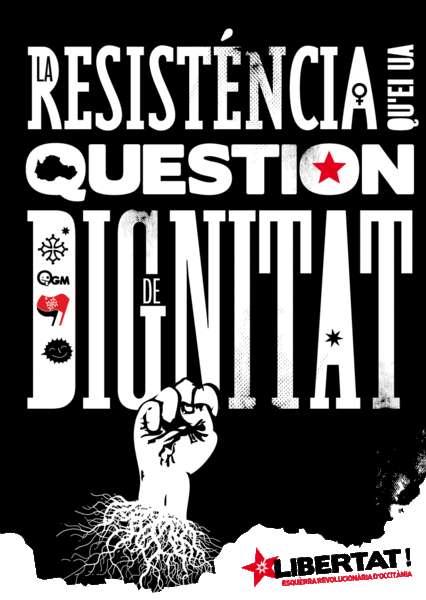Le sfide di questa disciplina alla luce delle nuove realtà geopolitiche. Il cattivo servizio reso dai partiti autonomisti. Gli “utili idioti” nostrani al servizio dello straniero. La questione demografica.
L’etnismo… Spiegare in poche righe quella che, sebbene relegata in un angolo, è filosoficamente l’altra metà del mondo rispetto alla cultura ufficiale (ossia del blocco monolitico formato dai politici, dai loro intellettuali e dai loro giornalisti), è un’impresa difficile. Per riuscirci bisognerebbe chiarire il suo significato. Che non è, come qualche ignorante si ostina a credere, la versione un po’ meno genetica del razzismo. Potremmo addirittura sostenere che ne è l’esatto contrario. Se i termini nascessero per mano di una commissione di esperti, non ci sarebbero problemi. Il razzismo sarebbe lo studio delle razze e l’etnismo quello delle etnie. Purtroppo le parole si creano in contesti storici che se ne infischiano dell’etimologia, per cui il razzismo è sinonimo di “persecuzione razziale”. E tale rimarrà per sempre.
L’etnismo invece è ciò che deve essere, ossia l’analisi delle caratteristiche culturali, psicologiche e linguistiche dei popoli. Allora perché non etnologia o etnografia? Per capirlo basta fare un esempio parallelo: ecologia ed ecologismo. L’ecologia studia l’ambiente. L’ecologismo, partendo dallo studio dell’ambiente, lotta anche per la sua difesa. Questi “ismi” in più servono a dare una connotazione, diciamo impropriamente, “politica” e fanno una notevole differenza.
Per approfondire, partiamo insolitamente dagli avversari. L’etnismo ne ha di nobili, come il cosmopolitismo, e di ignobili come i centralismi statali e il razzismo.
Il cosmopolitismo
Il cosmopolitismo ritiene che tutta l’umanità sia una grande famiglia, che dovrebbe parlare una sola lingua e limare via a poco a poco tutte le differenze locali. L’immagine “cittadino del mondo” è assai suggestiva e, ammettiamolo, inevitabile per molti individui con radici familiari disparate, poliglossia (ossia privi di un’unica lingua madre) e nessuna radice geografica.
Il cosmopolitismo è un atteggiamento onesto e positivo, ma ha due grossi difetti: è in antitesi con la struttura stessa dell’Homo sapiens, ed è la fotocopia ingenua degli intenti che animano le multinazionali e i poteri occulti. L’uomo nel modo più spontaneo e naturale si è sempre strutturato in gruppi con forti affinità interne; piccoli nella preistoria, poi sempre più grandi fino a un punto limite, in cui l’omogeneità si rarefaceva determinando una risuddivisione, ovvero un passo indietro verso dimensioni più adatte. Il fenomeno, secondo la candida visione del cosmopolitismo, è la causa delle guerre che infestano il pianeta dalla protostoria. Come dire che se il signor Gino litiga quotidianamente con la signora Maria, la vicina di pianerottolo, l’unica soluzione per porre fine a urla e ceffoni è che i due si sposino. La vera civiltà consiste invece nel fare in modo che le comunità vadano d’accordo, non che spariscano. Questo atteggiamento civile si chiama etnismo.
Il cosmopolitico, tra l’altro, auspica un’azione terribilmente distruttiva. Immaginate che a un certo punto qualcuno decida di invadere tutte le zone verdi della terra con una sola specie arborea (quale tra le centinaia, tra l’altro?), distruggendo tutti gli habitat, decimando gli animali inadatti e trasformando il mondo in un unico paesaggio. A parte il risparmio di cartoline – ne basterebbe una sola, da spedire ovunque ci si trovi – ci vivreste in un pianeta simile? Tornando all’uomo, per qual motivo dovreste provare il desiderio di visitare l’Olanda se l’Olanda non esiste più? Questa sorta di ogiemme umano che ne deriverebbe, sarebbe la manna dal cielo per le multinazionali: perché spendere tempo e denaro a rincoglionire le masse con il grandefratello o le americanate, quando in un colpo solo si otterrebbe un’umanità piatta, perfettamente programmata per i consumi?
Una sorta di laboratorio di cosmopolitismo sono gli Stati Uniti. Si dice che gli americani siano sempre avanti a noi: benissimo, questo ci offre il destro di osservarli in anticipo e prendere la direzione opposta. Centinaia di milioni di persone che, messa da parte la loro struttura atavica, parlano nello stesso modo, pensano nello stesso modo, mangiano nello stesso modo. Ma ciò che veramente conta, consumano nello stesso modo. Lì l’operazione è riuscita.
Il centralismo
Se il cosmopolitismo lastrica la via della catastrofe di buone intenzioni, non si può dire altrettanto del centralismo. La distruttività è quasi identica (si spazzano via solo le culture interne ai confini), ma gli intenti sono biecamente legati al potere e al suo sfruttamento. Con in più un’ipocrisia talmente macroscopica da non riuscire a convincersi che possa sfuggire (e sfugge) a milioni di cittadini. Gli statalisti – all’italiana, alla francese, eccetera – giocano infatti al cosmopolitismo quando guardano dentro la frontiera, e al nazionalismo quando guardano fuori. Le rivendicazioni di un gruppo etnico interno vengono definite “particolarismo” e accolte con la famosa frase ormai quarantennale: “Ma come, si parla di abbattere le frontiere e voi volete tirarne su delle altre?”. Dopodiché per i loro confini sarebbero disposti a fare la guerra, e l’atteggiamento nei confronti dell’“altro” più che al particolarismo assomiglia al disprezzo. Il separatista più virulento è maggiormente rispettoso del prossimo di quanto non sia l’esponente italiota medio quando enumera tutte le cose “che il mondo ci invidia” (l’importante è crederci), o irride gli svizzeri perché fanno gli orologi a cucù e non vivono in un porcile.
L’onnipresente razzismo
Quanto al razzismo, è forse il vocabolo più sfortunato dopo il verbo “scopare” (bandito dalla lingua ufficiale per via dei suoi significati secondari). Non solo non è mai stato lo studio delle razze, ma sta addirittura perdendo il suo contenuto storico, mutandosi in sinonimo di “pensiero non in linea con il potere”. In alcuni casi viene usato per denotare ideali o posizioni tali che un giorno finirà per diventare un complimento.
Tuttavia, ciò che il termine ancora esprime per le persone serie potrebbe rientrare nella seguente definizione: “Dottrina che, basandosi su presunte osservazioni scientifiche, decreta l’inferiorità biologica e culturale di un gruppo umano allo scopo di giustificarne la schiavizzazione o il genocidio”.
Come si vede è una cosa seria, terrificante. Un incubo che abbiamo vissuto sessant’anni fa, ma che attualmente non sembra il peggior spettro che aleggi sull’Europa. Anzi, a ben vedere non aleggia proprio per niente. Per riempirsi la bocca di questa parola, per vederla scritta in ogni articolo di giornale o in ogni dichiarazione di politico, è ovvio che bisogna darle un significato molto elastico. E a farne le spese più di ogni altra è la concezione che, invece, ha meno da spartire con il significato reale: l’etnismo. Si noti: il cittadino che esprime la sua antipatia per un altro cittadino non è razzista; il partito che dichiara il suo astio per gli avversari non è razzista; lo stato che muove recriminazioni contro un altro stato non è razzista; i poveri che odiano i ricchi non sono razzisti. Tutti i raggruppamenti di uomini possono avere un’opinione negativa d’un altro gruppo, o lamentare dei torti da parte di questo. Tutti tranne un gruppo etnico. Se lo fa lui è razzista.
Comunque se una nazione senza stato, una minoranza, una nazionalità, o come la vogliamo chiamare, decide di valorizzare la propria cultura e poi dotarsi di una politica autonomista o indipendentista, magari litigando con altri popoli, sono affari suoi. L’etnismo come disciplina si occupa di tutte le comunità, non di una in particolare, prendendo atto scientificamente dei caratteri di ciascuna e difendendone le aspirazioni. In base a un criterio assolutamente fondamentale: l’autoctonia. Banalizziamo pure con la frase: “Ciascuno è e deve essere padrone a casa sua”, se si preferisce. Sarà banale la frase ma non certo il concetto, se riflettiamo sul fatto che questo è il principio su cui ciascun essere umano fonda la propria esistenza. E un’etnia è solo un insieme statistico di esseri umani.
Resta il problema teoretico di cosa sia l’autoctonia, o meglio di quali princìpi cronologici ci si debba dotare per affermarla. Oggi, in base a limpidamente oscure scelte politiche, si diventa autoctoni per decreto, tempo qualche minuto. Un modo caustico per affermare che le forze antietniche temono a tal punto il concetto da volerlo estirpare alla radice proprio estendendolo a chiunque. Se invece si osserva la realtà umana, soprattutto europea, si noterà che non è troppo difficile riconoscere se un popolo è autoctono, ossia proprietario a tutti gli effetti del territorio in cui risiede, senza bisogno di promulgare regole cronologiche (ovvero, se sei arrivato lì enne secoli fa allora hai il certificato di autoctonia). Ovvio, come amano ripetere cosmopolitici, mondialisti e professionisti della fratellanza, che nella storia dell’uomo i popoli si sono naturalmente spostati, fusi, modificati. Naturalmente, appunto. Non artificialmente. Un conto sono le migrazioni spontanee, belliche comprese, verificatesi nei millenni, un altro sono le operazioni programmate a tavolino cui assistiamo da qualche decennio. La “chirurgia genetica” a base di spostamenti programmati è un’invenzione recente, tecnicamente impossibile nel passato.
Molti di noi ritengono scientemente che i flussi migratori di epoca fascista siano stati studiati dagli antropologi del regime per creare la “razza italiana”. Parimenti, molti di noi ritengono che per finalità immensamente più complesse sia in atto un’operazione analoga che usa come strumento chirurgico l’immigrazione extracomunitaria. Fatto strano, la denuncia di questo osceno complotto – mortale per le nostre culture e infame per chi viene sfruttato a tal fine – viene tacciata di razzismo. Il bue che dà del cornuto all’asino.
L’etnismo, al contrario, riconosce la bellezza e la ricchezza delle differenze umane. Nessuno che appartenga dignitosamente a questo filone di pensiero si è mai sognato di stabilire scale di valori, superiorità o inferiorità di sorta. Solo diversità, da apprezzare e incoraggiare. E partendo da una considerazione molto, molto importante: chi non ama se stesso è incapace di amare gli altri.
Il problema di chi si occupa a livello scientifico di etnismo, o ne fa un impegno politico, è – più ancora della censura dei media – di trovarsi a combattere contro avversari evanescenti, contro formule vuote e slogan. Chiunque abbia discusso con lo scemo del villaggio sa che è molto più complicato e snervante che affrontare un dibattito con un premio nobel. La frase fatta opposta a un concetto non è perdente, come verrebbe spontaneo credere. Viviamo in un mondo mediatico basato unicamente sull’apparenza, e ciò vale anche per i confronti di idee. Nell’imbonimento giornalistico e televisivo non conta quello che dici ma come lo dici. Esiste un apposito vocabolario studiato per chiudere la bocca agli avversari dell’establishment. I termini in sé farebbero ridere, ma su un pubblico non si sa se istupidito o atterrito dalla prospettiva di essere politicamente scorretto, hanno l’effetto di pallottole. Basta tacciare qualcuno di razzismo, xenofobia, intolleranza, blabla, e per magia un cittadino o un’organizzazione di cittadini sono fuori gioco. Più o meno quello che succede in un paesino: un piccolo pettegolezzo sussurrato, e una signora buona, altruista e timorata di Dio diventa automaticamente una puttana.
Chi orchestra tutto ciò, chiaramente, non rientra nella categoria scemo del villaggio. Lo saranno semmai le basse forze, più o meno numerose, che riesce a manipolare. Ma il manovratore no, sa esattamente quello che sta facendo e perché. La strategia dell’establishment italiano… e per establishment non intendiamo la coalizione di volta in volta al governo ma l’intero potere centrale… ha un’impostazione semplicissima: non ribattere mai alle argomentazioni con una controargomentazione. Tacere, e semmai avviare come per caso campagne a base dei soliti slogan, dei soliti concetti triti e ritriti.
Se uno studioso di storia enuncia fatti circostanziati che mettono in dubbio la santità del Risorgimento, mai rispondergli con la voce di un altro studioso (che difficilmente potrebbe smentirli): aspettare qualche giorno, poi inondare i quotidiani di articoli generici e squillanti sul tema. Come per dire al pubblico: attenti a non farvi venire strane idee, noi siamo qui e vegliamo.
Malgrado questo sia un articoletto generico, poco legato alla cronaca, ci si consenta un esempio clamoroso, quello della Turchia in Europa. La trovata, allucinante, è stata data per ovvia e non meritevole di spiegazione. Nessun giornalista se n’è mai occupato. Per anni. Finché qualcuno (non ultimo chi scrive) non ha deciso di sollevare la questione utilizzando tutti i mezzi possibili per far sapere ai cittadini che cosa li aspetta, e con argomentazioni riccamente e paurosamente basate sulla realtà dei fatti, tante da non poterle neppure nominare qui. Reazione automatica secondo il manuale: i giornalisti delle grandi testate vengono attivati, e così cominciano a comparire articoli di politologi che non ribattono a una che una delle tesi esposte da chi si illude che l’Europa abbia a che fare con gli europei. Chi ha la pazienza di rileggere, diciamo, una ventina di pezzi noterà che è impossibile ricavarne un senso. In pratica non si riesce a capire per quale motivo (rivelabile) la Turchia debba entrare in Europa. O meglio sì, frugando tra migliaia di parole, stereotipie, annaspamenti, si distilla che, insomma, la Turchia è un paese islamico moderato e, insomma, perdere l’occasione… Tradotto: ci accingiamo a distruggere l’Europa nella speranza che eventualmente un diciassettesimo del mondo islamico non abbracci l’integralismo.
Il politologo del Corriere o di Repubblica sta parlando sul serio o ci sta prendendo per i fondelli?
A che serve l’etnismo?
Le applicazioni di questa disciplina sono rilevanti. L’introduzione dell’antropologia nell’analisi delle interazioni tra i popoli permette di comprendere il significato di parecchi avvenimenti o di predirne altri.
Esiste una differenza sostanziale, soprattutto in Italia, tra un analista tradizionale e uno di estrazione etnistica. Il tradizionale non è meno preparato, ma se vuole continuare a insegnare in un ateneo o comparire in televisione deve affrontare ogni problematica prescindendo dall’aspetto etnico. In sostanza deve fingere che nelle vicende internazionali non siano coinvolti popoli, con la loro psicologia e il loro millenario e talvolta prevedibile modo di comportarsi, ma solo calcoli economici e militari, ideologie, al massimo religioni. Tutti aspetti che fanno sì parte di una comunità, ma che presi da soli non rivelano a sufficienza. Non accettando l’interpretazione personale che ogni popolo dà di queste categorie, si tende a creare regole generalistiche per ogni voce, salvo poi chiedersi perché non abbiano funzionato.
Per esempio, il crollo dell’Unione Sovietica è stato repentino e ha colto di sorpresa quasi tutti, ma era prevedibile perché l’Urss era un impero multietnico, e gli imperi multietnici non possono durare. I loro popoli alla lunga non li tollerano. Non ricordiamo di aver letto una spiegazione simile.
Quando la Lega Nord raggiunse il 20% alle elezioni, gli analisti affermarono che si trattava di un voto di protesta: la loro struttura mentale era semplicemente incapace di pensare che una popolazione, maltrattata e insultata per decenni in nome dell’italianità, potesse riconoscersi in qualcosa di diverso. Malgrado i loro libri spesso illeggibili, così lontani dalla semplicità dei grandi studiosi anglosassoni, non si erano accorti di fenomeni abbastanza visibili in quel periodo.
Dalle tv locali alla Iugoslavia
Nessuno ha mai sottolineato l’apporto (involontario) delle nuove tv locali e della stessa Fininvest nel risveglio del nord. Per la prima volta dal ‘54 “la televisione” mostrava l’esistenza di esseri umani viventi a nord dell’Appennino. I telegiornali avevano speaker con accenti non romano-napoletani. Si udivano frasi in lingue padane, laddove la Rai le aveva censurate (sì, censurate) per decenni. I meno giovani ricorderanno che la volta all’anno in cui si sentiva risuonare un vocabolo nordico, seguiva immancabilmente la traduzione e talvolta un commento insultante (tipo “ostrogoto”). Se un cittadino intervistato si lasciava scappare un’espressione alloglotta, veniva bruscamente invitato a parlare italiano, mentre l’abbonato bolognese o torinese poteva sorbirsi ore di Eduardo senza sottotitoli. Ma gli analisti non prendevano il tram (gli analisti, i politici e i giornalisti celebri non prendono mai il tram) e quindi non avevano udito i mugugni di praticamente tutti i cittadini del nord, operai comunisti compresi, dall’epoca del boom in poi.
Né si erano accorti, gli analisti, dell’effetto psicologico provocato dalla polverizzazione iugoslava, con i “cattivi” sloveni e croati che salutavano e se ne andavano. Ah, la balcanizzazione, il rischio di destabilizzare la regione… Gli analisti! Che si tapparono la bocca quando la comunità internazionale accolse a braccia aperte i nuovi stati, senza rendersi conto che per la prima volta, a due passi da casa, si era dimostrato come fosse possibile separarsi da uno stato sovrano senza che un fulmine incenerisse i colpevoli. Il tabù della separazione si era incrinato.
Non gli analisti e i politologi, ma il salumiere all’angolo avrebbe dovuto intuire che stava succedendo qualcosa quel giorno del 1988 in cui il Milan vinse lo scudetto e, fatto unico nella storia del calcio, venne festeggiato dalle bandiere di tutte le squadre del nord. Aveva strappato il trofeo al Napoli, dopo che per mesi un coro assordante e ben diretto aveva cantato la “necessità” che i partenopei lo portassero a casa, semplicemente perché la città ne aveva diritto. Se costoro avessero frequentato le case (ma gli intellettuali non frequentano le case), avrebbero visto massaie milanesi che odiavano il calcio lanciare grida di gioia ed esporre bandiere rossonere. Cos’era questa, una forma di lotta contro la finanziaria?
Dunque, mentre gli analisti etnici registravano tutto ciò, gli altri parlavano di voto di protesta. E quando la Lega cominciò a declinare dissero e dicono tuttora: “Visto?” Visto cosa, di grazia? Che l’economia si era irrobustita? Che i partiti di tangentopoli si erano decisi a cambiare nome? Che delinquenza e disoccupazione erano diminuite? Che, insomma, non c’era più motivo di protestare e si poteva tornare a votare come persone per bene? Gli analisti, si stenta a crederci, ne sono convinti. Beati loro, poiché a noi, invece, resta solo da prendere atto che la Lega ha monopolizzato il padanismo e l’ha mandato a rotoli. Come? Distruggendo l’iniziale anima etnistica; mettendo in campo una mancanza di cultura da fare invidia ai centralisti; rifilando a Milano “quel” sindaco.
Nuovi problemi
Abbiamo citato la Lega Nord perché la sua comparsa ha segnato una svolta, non tanto nell’etnismo teorico, quanto nel modo in cui esso viene percepito dalla cittadinanza non “preparata”. Tradotto: l’etnismo, e una delle sue possibili applicazioni, l’autonomismo, era fino agli anni ‘80 qualcosa di esoterico per colpa delle censure, ma accolto con grande simpatia da chiunque ne venisse in contatto. La Lega ne rese propri alcuni aspetti, li elaborò, e li fece conoscere praticamente a tutti. Sicché oggi l’unica versione “ufficiale” della nostra disciplina è quella leghista. Dovremmo dire grazie a Bossi per aver fatto in pochi anni ciò che a noi non è riuscito in decenni? Sì, perché almeno una realtà etnica d’Italia, la Padania, è oggi conosciuta in tutto il mondo. No, perché ogni volta che la citiamo siamo costretti a spiegare, primo, che non l’hanno inventata i leghisti, secondo, che il significato originario è molto diverso.
Per quanto riguarda l’autonomismo in generale, il leghismo ne ha incanalato la vocazione naturale nelle strettoie della politica partitica, con precise connotazioni di parte. In Italia, insomma, l’autonomismo è una cosa di “destra”; laddove, per esempio, in Francia o Spagna è prevalentemente di sinistra. Lo diciamo tanto per dire, poiché l’autonomismo non dovrebbe essere nulla del genere: solo un veicolo per affrancare una comunità che in seguito, una volta autodeterminata, voterà come le pare.
Tornando al consueto parallelo ecologico, è la stessa situazione proposta dai verdi italiani, che spingono molti a chiedersi perché per difendere la natura si debba contemporaneamente abbracciare determinate ideologie. Un autonomista, a sua volta, può giusto scegliere se battersi in solitudine oppure aderire alle politiche demografiche stile ventennio o a concezioni clericali da paleolitico. Se un gay, di per sé sensibile al problema della minoritarietà, volesse imboccare l’autonomismo, al giorno d’oggi dovrebbe fare una certa violenza su se stesso.
La scriteriata macchina italica che impacchetta tutto lo scibile in confezioni di destra e di sinistra ha ricevuto ulteriore carburante da un certo autonomismo nordico, mettendo a malpartito l’etnista puro (o il piemontesista, o il padanista, o il celtista…). D’altronde, a rendere ancora più imbarazzante il suo cammino c’è il fatto innegabile della parentela. Nel panorama politico italiano non esiste alternativa: tutti sono reazionari e centralisti, dall’estrema sinistra all’estrema destra, cosicché chi ama la propria terra e la propria lingua è costretto a scelte dolorose: votare il nemico, oppure abdicare alle proprie idee in campo etico, economico e sociale, dando la preferenza ai soli che si battono dentro le istituzioni contro il massacro delle etnie e dell’Europa “europea”. Decisione evidentemente troppo dolorosa, quest’ultima, viste le percentuali elettorali irrisorie ottenute negli ultimi anni dai “parenti”.
Torna lo “spettro”
Tutt’altra faccenda è l’etichettatura xenofobica data all’etnismo e all’autonomismo dalle forze centralistiche, indipendentemente dalla Lega e dalle sue colpe. In effetti, alle questioni tradizionali di cui si occupava “Etnie” negli anni passati – la difesa dei popoli europei contro gli stati centrali – si è aggiunto il problema della difesa dell’Europa dall’“esterno”; o meglio, da quelle forze interne che usano tale “esterno” per distruggere il nostro tessuto sociale. Il fenomeno ha assunto proporzioni talmente immani da far passare in secondo piano le precedenti.
Alcuni di noi hanno monitorato il fenomeno sin dai tardi anni ‘80: dichiarazioni di politici sulla necessità imprescindibile di creare una società multirazziale, proiezioni genetiche (tipo “tra vent’anni saremo 20 milioni di italiani e 30 di stranieri”, quando non c’era ancora un extracomunitario all’orizzonte), caccia spietata dei media agli episodi di razzismo a danno dei primi stranieri (famoso quello del marocchino che, nella “cattiva” Brianza, a forza di scaricare la spazzatura nel giardino di un autoctono finì per buscarsi una gragnuola di pedate: “grave atto di intolleranza nel feudo della Lega”, scrissero i giornali), marce di protesta contro il razzismo (in realtà contro poveri pensionati che, non riuscendo più a uscire di casa senza essere aggrediti, chiedevano comprensione alle autorità), manifestazioni antixenofobe con in testa Dario Fo con colbacco, giocolieri e attivisti sui trampoli.
Tutto ciò sembrava frutto di una regia studiata fin nei minimi particolari, e molti di noi credettero che si trattasse del trucco politicamente più antico del mondo: cementare l’unità del Paese in un momento di fortissime spinte centrifughe, non più con il classico espediente di dichiarare una guerra a uno stato confinante, ma portandosela in casa. Un episodio che parve illuminante, quantomeno a chi scrive, fu la celebre piazzata di un sindaco milanese (ovviamente prima di “manipulite”) che assalì i tramvieri al grido di “razzisti”, “fascisti”, “nazisti”. I lavoratori, che protestavano per i disagi causati da un accampamento di extracomunitari, reagivano con insulti dai variopinti accenti padani e meridionali. Un’unità finalmente ritrovata contro un nemico comune, in apparenza; un’operazione mirabilmente calcolata dal centralismo. In base a questa analisi, il parziale cambiamento di rotta della Lega dall’anticentralismo all’antinvasionismo parve ad alcuni di noi la caduta in una trappola ben riuscita. E in effetti il padanismo (“quel” padanismo) si intiepidì parecchio. Tuttavia, pur senza escludere che l’establishment sul fenomeno “ricompattamento” ci abbia marciato, oggi sappiamo che l’analisi di base era sbagliata.
L’apparente politica invasionista non era, o meglio non è generica. Come si sarà notato, portata a termine la prima fase del piano – l’invasione, le leggi per favorirla – adesso non si calca più la mano sulle culture straniere in quanto tali, ma solo su quelle islamiche. Africani neri, asiatici, latino americani, ormai possono anche andare a farsi benedire, l’interesse pilotato dei media va solo alla comunità che, per il momento, non è neppure la più numerosa. Il complotto c’è, esiste, ma non è una trovata antiautonomista italiana, bensì un’operazione concertata a livello europeo per favorire l’Islam. Bisogna rendere onore alla Fallaci per avere indicato i veri retroscena e per averli documentati. Tutti noi vorremmo che la giornalista si fosse sbagliata, che le sue tesi fossero un cumulo di fesserie, ma purtroppo ogni quotidiana osservazione non fa che renderle più solide ed evidenti.
Quindi, a malincuore, chi si occupa di culture europee non può fare a meno – si potrebbe dire trascinato per i capelli – di affrontare anche il problema islamico, in quanto l’Islam ha come fine, scritto nero su bianco, la conquista dei nostri popoli. Occuparsene significa incorrere nella reazione dei collaborazionisti e del loro patetico arsenale terminologico a base di razzisti, nazisti, intolleranti, eccetera. Ma bisogna tener duro, se non vogliamo che Friuli, Bretagna, Frisia, Scozia, diventino un ricordo da libri (clandestini) di storia. Questo è uno dei motivi per cui alle normali trattazioni etnistiche si dovrà affiancare parecchia geopolitica.
D’altronde ogni periodo storico ha le sue priorità. Dubitiamo che nell’Europa invasa dai nazisti le “nazioni senza stato” vedessero come questione primaria l’autonomia amministrativa o l’insegnamento della lingua. Per noi la suddetta questione ha ancora un significato enorme e intatto, ma siamo consci del fatto che una catastrofe molto simile si sta per abbattere sul continente a sessant’anni di distanza. Qualcosa che ha le sue analoghe regole criminali e il suo Mein Kampf. Come allora, l’attendismo e l’incredulità – lo temiamo – cederanno il posto alla coscienza e alla disperazione quando sarà troppo tardi. E riesce difficile credere che chi ha fatto la Resistenza per conquistare la democrazia e la dignità della donna non senta prudere le mani; che, proprio nel nome della fedeltà ai propri ideali, non si rivolti contro quelle forze politiche che li stanno calpestando, gli ideali, per quattro barili di petrolio. Mentre le SS nostrane – neonazisti, brigatisti, toninegristi – la loro scelta l’hanno già fatta. Come si dice, il cattivo sarà anche meno intelligente ma certo è più sveglio.
Riassumendo, per quanto riguarda l’aggressione islamica dobbiamo difenderci non tanto dagli imam (che presi a sé farebbero ridere i polli), quanto da una setta intestina formata, se non ci sbagliamo, da tre principali congreghe: i potenti che hanno firmato accordi, di cui esiste documentazione, per la creazione dell’Eurabia con alcuni paesi islamici (detti “moderati” ma di fatto fascisti); i nazisti di vario colore, decisi a sfruttare le masse maomettane per scardinare l’ordine europeo; un gregge non cattivo… non più di quelli che gridavano Heil Hitler negli anni ‘30 perché lo facevano tutti… ma psichicamente poco autonomo di sedicenti progressisti e cattolici suicidi. A ciò va aggiunta una strategia oscura degli Stati Uniti – che bisognerà studiare con grande attenzione – la quale nel migliore dei casi vuole utilizzare l’Europa come cane da guardia dei suoi alleati militari (vedi Turchia), nel peggiore vuole farci a pezzi prima che diventiamo una superpotenza.
Un club cristiano?
Un’altra caratteristica storica dell’etnismo è di essere irriducibilmente europeista. Dispiace quindi vedere l’atteggiamento quasi opposto di alcuni autonomisti di cittadinanza italiana. Certo, l’Europa della “setta” farebbe venir voglia di andarcene armi e bagagli o di federarci con la Svizzera, ma abdicare ai propri ideali per quattro malfattori è veramente troppo. È come se i cittadini di uno stato sudamericano volessero ridurre a zero i poteri della polizia in quanto corrotta. Perché attaccare un’istituzione utile e non i suoi esponenti? Oltretutto, non siamo forse noi a votarli? Massima comprensione per chi obietta che basterebbe la querela di un imam francese a farci finire in una prigione di Marsiglia, per la storia del mandato di cattura internazionale, eccetera; ma perdio, abbiamo combattuto decenni al fianco dei federalisti europei per mandare tutto a rotoli a causa di un imam? Dobbiamo ritrovarci dall’altra parte della barricata difendendo la sovranità italiana, quando abbiamo sempre sostenuto che l’Europa dei Popoli passa attraverso l’indebolimento degli stati nazionali?
A proposito di Europa: si tratta realmente di un “club cristiano”? Per alcuni esponenti etnici lo è. Il cristianesimo viene visto come un elemento indissolubile della nostra storia, al punto da assumere il ruolo di “tratto etnico” al pari della lingua. Il problema è che un “tratto” costituisce per definizione soltanto una tra le caratteristiche dell’etnia (o, parlando d’Europa, di un’insieme di etnie che compongono una civiltà). Non è un caso che, a differenza dei commentatori tradizionali, gli etnisti considerino quello dell’Ulster non un conflitto confessionale ma etnico, tra irlandesi puri (i cattolici) e invasori anglosassoni e scozzesi (i protestanti). Per di più la civiltà europea, sotto la voce “religione”, ha elaborato contemporaneamente il giudaismo, l’ateismo e l’agnosticismo, senza contare tutto l’immenso patrimonio nascosto di esoterismo, magia rinascimentale, alchimia, druidismo, eccetera. Quindi – ed è un parere personale – un etnoautonomista dovrebbe evitare di prendere posizioni “politiche” su temi religiosi (di nuovo viene da tirare in ballo la Lega e chiedere: un padano non credente come dovrebbe comportarsi?).
Però c’è un problema… La diatriba ormai secolare tra laici e religiosi non è più una questione interna. Ormai non c’è verso di affrontare questioni in forma “privata”, senza che ci mettano il becco gli islamici, o meglio i loro portavoce. Nei consueti dibattiti sul crocefisso nei luoghi pubblici, i commentatori laici fingono di difendere il cittadino non credente, mentre in realtà stanno dando voce alle pressioni delle comunità straniere. Quindi togliere il crocefisso equivale a cedere ai ricatti di qualcuno che viene a comandare a casa nostra. Quindi le raffigurazioni religiose diventano simboli etnici anche quando non lo sarebbero. Quindi, chi in tempi normali si batterebbe contro l’imposizione clericale, oggi finisce per difenderne l’iconografia per puro spirito reattivo. Ciò è comprensibile ma non giustificabile. Reagire a un’imposizione abdicando ai propri princìpi equivale a darla vinta al nemico. Un esempio clamoroso di autolesionismo? Il divieto francese di esibire i simboli religiosi nelle scuole. Nessuno, fino a pochi anni fa, si sarebbe sognato di protestare per una scollatura allietata da una bigiotteria cruciforme. Ora è proibito, al solo scopo di evitare che le studentesse magrebine arrivino in burka. Lo stato francese è talmente incapace di gestire la sua paurosa immigrazione, da limitare in modo ridicolo i diritti dei propri cittadini. Un po’ come reagiscono certi genitori troppo buoni o troppo scemi quando il figlio degli ospiti mette a soqquadro la casa, e lo fanno smettere tirando un ceffone al proprio. In un Paese decente, io posso chiedere che si tolga il crocefisso da un’aula, ma se lo fa Adel Smith dovrà essere caricato immediatamente sul primo aereo per il Cairo.
Da notare che chi difende le etnie, tutte le etnie, vede di cattivo occhio anche l’operazione inversa, ossia l’esportazione del cristianesimo presso popolazioni di cultura totalmente differente. Con tutto il rispetto per molti missionari, che fanno davvero del bene, va pur detto che se i loro predecessori se ne fossero stati a casa propria certe situazioni agghiaccianti del Terzo Mondo si sarebbero evitate. Se vogliamo difendere l’Europa dalla distruzione, dobbiamo noi per primi riconoscere i misfatti di cui ci siamo macchiati nei secoli scorsi contro genti che ritenevamo incivili. E questo, finalmente, è il vero razzismo: non solo l’invasione coloniale e lo schiavismo, ma anche l’imposizione di ideologie come la sessuofobia cristiana e il marxismo, che hanno distrutto il tessuto culturale ed economico di intere popolazioni. Le stesse, in parte, che oggi bussano ai nostri confini.
Se i terzomondisti di professione non fossero della stessa genia dei colonialisti, se amassero davvero i popoli in difficoltà invece di usarli come arma per regolare i loro conti ideologici con l’Occidente, si risolverebbero un sacco di problemi. Immaginiamo se ogni stato europeo ne “adottasse” uno africano, fornendogli fondi, tecnologie, formazione (non pesce ma canne da pesca, come si dice). Dal punto di vista antropologico ci sarebbero scambi culturalmente affascinanti, ben diversi dalle infami invasioni tanto care ai nostri politici. Ma evidentemente è più caritatevole distribuirli a migliaia sotto i ponti o ai semafori, che renderli dignitosamente indipendenti a casa loro. Ah, già, dimenticavamo: abbiamo bisogno di braccia. Ammesso che non sia una palla colossale, bella motivazione umana, davvero.
Figli alla Patria
“Le culle sono vuote!” Questa frase straziante, se la memoria non ci inganna, è la primissima formula subliminale usata dai politici alla fine degli anni ’80 per preparare i popoli italiani alla futura invasione extracomunitaria. Fino a un attimo prima, per antropologi e demografi il problema si chiamava sovrappopolazione. C’era stato, è vero, nell’84 un congresso a Bucarest in cui Vaticano e comunisti avevano proclamato che, spianando foreste e interrando mari, si sarebbe ottenuto cibo per venti miliardi di individui, ma la prospettiva non aveva suscitato entusiasmo. Fatto sta che se le culle erano vuote, la drammatica carenza di popolazione andava risolta con l’innesto di milioni di stranieri. Interessante, ancora una volta, la contromisura leghista: sfornare figli per contrastare l’invasore. Sempre per la serie facciamoci del male.
Ora, non risulta una posizione dichiarata dell’etnismo sul tema demografico. In fondo non c’entra molto con la difesa di lingue e culture. C’è però un concetto, il “minusvalore”, molto in voga nell’ambiente, secondo il quale esistono ricchezze non quantificabili in denaro ma assai più preziose, o comunque irrinunciabili. Gli etnisti le individuano nella conservazione della propria identità storica, nel non snaturamento che porta solo infelicità e confusione interiore. Ma in generale si può dire che minusvalore è tutto quanto, finanze a parte, contribuisce a migliorare la qualità della vita. È evidente che una realtà geografica sovrappopolata non rappresenta il posto migliore per vivere felici.
La prossemica studia il rapporto tra gli uomini in base agli spazi, e stabilisce che due individui non gradiscono di essere separati da una distanza troppo breve. Tale distanza, ovvio, è calcolabile anche in base alla variabile “affinità”, e può diventare zero nel caso di due amanti, di madre e figlio, eccetera. Ma due sconosciuti faticano a condividere un ascensore. Moltitudini di sconosciuti, per esempio in una città, su una spiaggia d’agosto, in fila sull’autostrada, subiscono un continuo bombardamento “prossemico” che alla lunga rende nervosi. Immaginiamo un trattamento simile per molte ore al giorno e per tutti i giorni dell’anno, e capiremo perché si usa dire che gli abitanti di una grande città sono nevrotici.
Sociologi, politologi e sindacalisti potranno anche inventarsi dozzine di spiegazioni, dando la colpa a questo o a quel disservizio, a questa o a quella carenza di strutture, alla viabilità caotica, agli orari di lavoro, insomma a tutto lo scibile metropolitano, ma non riusciranno mai a spiegare l’unica vera ragione per cui quasi tutti i milanesi hanno bisogno di uno psicanalista, mentre gli abitanti di un borgo toscano sono sorridenti e dormono notti tranquille. Il motivo è l’enorme quantità di individui in spazi paurosamente ridotti. Un condominio può contenere la popolazione di un piccolo paese, ma osservate la differenza di rapporti tra gli abitanti. Si suole affermare che in città non si conosce il vicino di pianerottolo. In città va così, si dice. Va così non è una spiegazione. Diciamo piuttosto che un palazzo è un contenitore in cui un individuo si trova a un paio di metri dagli altri, separato da un muro di cartavelina, e capiremo perché si è evoluta una nuova sottospecie, l’Homo sapiens condominialis, il cui compito principale è litigare con i vicini, tempestare l’amministratore di telefonate, affiggere cartelli minacciosi. Il soggetto è stravolto dall’incombere del sovraffollamento ed esprime il suo malessere con l’aggressività.
La variabile “affinità”, perché non dovrebbe manifestarsi anche in questa applicazione collettiva della prossemica? L’introduzione di elementi “alieni” a una società tende ad aumentare il raggio medio all’interno della quale scattano i meccanismi di difesa. Inutile, ancora una volta, cercare spiegazioni sociali in quella che è una semplice reazione antropologica, non controllabile a meno di non intervenire geneticamente. Riempire una città di stranieri significa incrementare proporzionalmente il livello di nevrosi. Chi afferma che tutti i tentativi di società multirazziale sono falliti, non sempre sta trovando scuse per propagandare idee hitleriane: a volte, magari a malincuore, si limita a osservare che in tutte le realtà urbane composite i gruppi umani si insediano o si spostano in modo tale da creare microcittà, veri e propri ghetti, separate tra loro da metri che hanno il peso di decine di chilometri. Impenetrabili. Non comunicanti. Questo si intende per fallimento, anche senza contare le violenze e i fatti di sangue. Chi vuole “onestamente” una società multirazziale dovrebbe chiedersi se essa sarà tale solo per la pura e semplice presenza di genti diverse, perché in questo caso l’impresa sarà un gioco da ragazzi. Sembra la scelta operata dall’establishment europeo e italiano in particolare.
L’idea di riempire culle – culle autoctone – al punto in cui siamo è un vero colpo di genio! Significa aumentare il sovraffollamento nella speranza… di cosa? Che i giovani, crescendo, scaccino gli immigrati? Che con tante braccia a disposizione non se ne debbano più importare dal Terzo Mondo? Ma non si ama forse dire che siamo pieni di disoccupati perché i nativi si rifiutano di svolgere certi mestieri? Per quale alchimia i nuovi nati saranno più disponibili? E soprattutto, siamo certi che le nostre autorità importino masse solo per rendere felici quattro industrialotti veneti? L’idea che uno stato europeo possa contrastare miliardi di individui a colpi di neonati è assolutamente esilarante. E suicida.